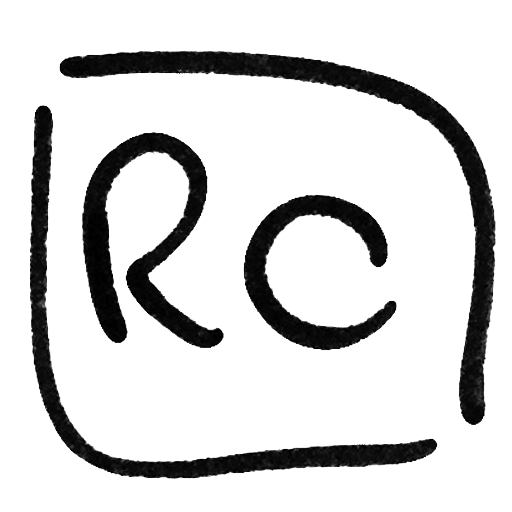Parole Jelinek. Lieder
[A text I wrote in 2015, published then in the Italian online magazine doppiozero and slightly re-edited]
Elfriede Jelinek nasce nel 1946 a Mürzzuschlag nella Stiria, ma cresce a Vienna, capitale della musica. La madre incoraggia con un certo accanimento i suoi studi musicali e a soli 13 anni Jelinek viene ammessa al Conservatorio di Vienna, dove studia organo, pianoforte e composizione, contemporaneamente dedicandosi al flauto dolce e alla viola in una scuola civica musicale. Parallelamente frequenta le scuole pubbliche e dopo la maturità studia Scienze teatrali e Storia dell’arte all’Università di Vienna, ma è costretta ad abbandonare gli studi universitari per via dei frequenti attacchi di panico.
Per un anno dunque Jelinek resta chiusa in casa in completo isolamento: è questa l’epoca in cui inizia a scrivere e sarà al Conservatorio che porterà quindi a termine gli studi nel 1971, diplomandosi come organista sotto la guida di Leopold Marksteiner. Musicista, quindi, prima ancora che scrittrice. Non per niente la motivazione del Nobel recita “per il flusso musicale di voci e controvoci” e non per niente una grandissima parte della sua produzione è strettamente legata alla musica.

Erstarrung – to the play Winterreise, ph. © Roberta Cortese
Se il suo testo più ‘popolare’ è infatti il romanzo La pianista, molti altri testi di Jelinek hanno fatto da vero e proprio libretto o sono stati comunque punto di partenza per composizioni musicali di vario genere, anche di tipo più sperimentale. E pur essendo l’autrice solitamente giudicata un’outsider, una solitaria, in ambito musicale il suo nome è invece da anni legato a quello della compositrice austriaca Olga Neuwirth, con cui numerose sono state le collaborazioni. Volendo poi guardare alla produzione teatrale, salteranno subito all’occhio tutti quei titoli che ammiccano ad altrettante opere musicali, dal Così fan tutte di Mozart al movimento L’addio della Sonata per pianoforte n. 26 di Beethoven.
Priorità quasi assoluta ha però a questo riguardo la produzione liederistica di Franz Schubert, notoriamente il musicista preferito di Jelinek. Infatti, dopo Fa niente. Piccola trilogia della morte, che racchiude La regina degli elfi, La morte e la fanciulla [I] e Il viandante, e dopo la serie dei Drammi di principesse – La morte e la fanciulla I-V, fra le ultime fatiche teatrali di Jelinek c’è un’intera Winterreise, ispirata ovviamente al ciclo schubertiano su liriche di Wilhelm Müller. Il testo è suddiviso in otto parti e ciascuna prende le mosse da un Lied; come sempre si intrecciano vicende sociopolitiche, scandali e autobiografia (torna la figura del padre, già protagonista de Il viandante), ma qui più del solito sono numerosi, perfettamente integrati nel testo, i rimandi diretti alle liriche di Müller, che non possono fare a meno di evocare, per lo meno in chi le conosce, le melodie a cui hanno dato vita.
Sempre in ambito teatrale, tra i compositori di Lieder ridotti invece direttamente a soggetti ‘agenti’, abbiamo non soltanto Robert Schumann (cui è dedicato il monologo Il tacere), ma anche la moglie Clara, protagonista, assieme al marito, di Clara S. Tragedia musicale. Clara Schumann infatti, oltre ad essere eccellente pianista, di Lieder ne scrisse a sua volta, pur restando nell’ombra a cui era predestinata in quanto artista donna. E qui si potrebbe aprire una voragine sul discorso relativo alla scrittura/composizione femminile opposta a quella maschile, discorso di cui è intrisa altrettanta produzione di Jelinek; limitiamoci invece a evidenziare un particolare non troppo noto, ma non per questo meno significativo, che mette in nuova luce il rapporto tra Jelinek e questa branca della musica da camera, il Lied. Tra il 1965 e il 1966, prima ancora di scrivere romanzi e testi teatrali, la cui produzione ha inizio praticamente negli anni ‘70, Elfriede Jelinek compone tre Lieder. Uno, per soprano e clavicembalo, su un testo di François Villon, gli altri due, invece, Klage (Lamento) e meine liebe (amore mio), per soprano e pianoforte, su liriche della stessa Jelinek.
Klage
du hast mich
durch die flöte gezogen
wie einen schrei…
die saiten deiner harfe
haben löcher
in mein gesicht
gerissen…
du hast mir mein rot
genommen-
und meine stimme…
trocken
sind meine lippen
und meine augen
hat der weinevogel
in den wind
gestreut…
Lamento
mi hai / tirata per il flauto / come un grido… / le corde della tua arpa / han lasciato / strappi / sul mio viso…/ mi hai preso / il rosso – / e la voce… / secche / son le mie labbra / ed i miei occhi / li ha sparsi / al vento / l’uccello del pianto…
meine liebe
und tanzt
der eberesche
früchter wind…
der liegt verrauscht
an blütenstaubes tod…
es blaßt dein lächeln
schwinger saum
von vogelzügen…
alles gold
an deiner hand
bin ich…
warum verströmt der garten
mich
deine ringe
an schmetterlingsfremdheit…
ich kenne
deine leeren hände
nicht…
amore mio
e danza / al sorbo selvatico / vento di frutti… / giace ebbro / di morte di polline… / impallidisce il tuo sorriso / orlo d’ali / di migrazioni… / tutto oro / sulla tua mano / sono io… / perché il giardino emana / me / i tuoi anelli / a estraneità di farfalle… / le tue / mani vuote / non le conosco…

Die Bankbraut, to the play Winterreise, ph. © Roberta Cortese
Musicalmente i due Lieder seguono, se anche non troppo rigidamente, le regole della dodecafonia. Jelinek bada senz’altro a che il testo, nonostante l’estensione non indifferente della linea melodica, conservi la sua comprensibilità (cosa non affatto scontata, tra i compositori moderni) e l’accompagnamento è discreto, segue il testo sottolineandolo, a tratti, in termini quasi didascalici. Difficile, naturalmente, esprimere giudizi o valutazioni di fronte a una produzione di entità tanto ridotta e si possono avanzare solo speculazioni sulle ragioni che hanno portato Jelinek a non proseguire la sua ricerca prettamente musicale imbarcandosi in un’impresa senz’altro difficile, ossia quella del tentare una carriera da musicista nell’Austria degli anni ’60, che nel concreto ha dimostrato di non avere spazio da offrire a compositrici, ma solo a compositori. Resta il dato di fatto che Jelinek abbia rinunciato alla composizione e resta una sua dichiarazione in uno scritto dedicato a Patricia Jünger, che ha composto musiche per alcuni suoi testi:
“Ci vuole una gran forza a compiere i primi passi da yeti in un campo vasto e inospitale come la musica, abitato da geni maschili e da paguri giganti (abitano nei corpi delle loro donne!), in cui il processo di esclusione nei confronti delle donne è stato efficace come mai altrove nell’arte.” (Elfriede Jelinek, Die Komponistin. Über Patricia Jünger [La compositrice. Su Patricia Jünger], in Ich will Kein Theater. Mediale Überschreitungen, a cura di Pia Janke & Team, Praesens Verlag, 2007).
La domanda che sorge spontanea a questo punto è se Jelinek abbia davvero abbandonato la composizione, abbia davvero smesso di fare musica, o se non l’abbia per così dire immessa nella sua scrittura. Si tratta, però, a ben guardare, di due questioni distinte, per cui comporre e fare musica non sono necessariamente sinonimi. Innanzi tutto, quindi, qualche piccola precisazione riguardo a certi luoghi comuni, alimentati peraltro da dichiarazioni della stessa Jelinek. Lei per prima, infatti, non rinuncia a definire il suo processo di scrittura in termini musicali: affermazioni come “Lavoro in maniera assolutamente compositiva”, o “In fondo, è un intreccio contrappuntistico, quello che cerco di creare” sono abbastanza comuni; così pure, soprattutto in riferimento a ‘esecuzioni’ di suoi testi, ci si imbatte molto spesso nel termine “Sprachpartitur”, “partitura di linguaggio”. Nel concreto, però (e questo anche a conferma delle tesi di Pia Janke, studiosa di Jelinek; vedi Jelinek Handbuch, a cura di Pia Janke, Verlag J.B. Metzler, 2013), non è possibile rintracciare, nei testi teatrali di Jelinek (ché sono poi questi, quelli concepiti per dare vita a suoni reali), una ‘forma’ vera e propria, una struttura riconducibile a una qualunque prassi compositiva in senso prettamente musicale.
Resta, innegabile, una musicalità estrema, quasi congenita, del linguaggio, in cui l’attenzione al suono della parola affianca sempre quella data al senso (Wolfgang Reiter), e a cui molto contribuiscono i famosi giochi di parole, i calembour in discesa libera. E il pregio di Jelinek sta, a mio parere, proprio in questa ambiguità: nel riuscire a fare musica a un livello diverso, per cui ad esempio le omofonie che ricorrono nelle singole frasi si intrecciano e si accavallano dando vita ad altre omofonie ancora, e davvero finiscono per comporre strutture dalle valenze melodiche, ritmiche e perfino dinamiche, strutture che a partire da una frase vanno ad estendersi a paragrafi interi, dando forma a quelle “superfici di testo” che un po’ spaventano l’interprete predestinato, perché paiono senza appigli, ma che poi, inspiegabilmente in apparenza, ma in realtà proprio in virtù di questa musicalità congenita, finiscono per fissarsi nella memoria in maniera quasi autonoma (e restare impresse anche a distanza di molto tempo, aggiungo).

Foto dall’ anteprima torinese di Winterreise a S.Pietro in Vincoli © Silvana Genovese
Jelinek abbandona, quindi, la composizione in senso stretto, per poi scrivere testi teatrali dal linguaggio fortemente musicale, che ostentatamente e in volumi sempre maggiori (Winterreise è un libro di 220 pagine, per una durata di lettura integrale di circa 3 ore e mezza) rimandano ad altri Lieder, primi fra tutti quelli di Franz Schubert. Parafrasando Müller in Erstarrung (Congelamento, Winterreise, 4.): “Cerco invano nella neve l’impronta dei suoi passi”, sembrerebbe inutile cercare paralleli strutturali tra i Lieder di Schubert e le superfici di testo di Jelinek. L’affinità prima è sicuramente a livello di sensibilità, laddove la figura di Schubert si sovrappone a quella del suo viandante, che (un po’ come Jelinek, del resto) è un outsider, un anti-eroe che vaga per sentieri solitari e inospitali e che in conclusione erra (in modo assolutamente bivalente, ossia vaga e cade in errore) innanzi tutto in se stesso, che non è leader nemmeno di se stesso. Come non cogliere le similitudini con gli elementi autobiografici attraverso i quali Jelinek si offre continuamente (apparentemente) in pasto al suo pubblico? Eppure c’è di più e la chiave per comprendere la scrittura jelinekiana, in cui lo spettatore spesso si perde, risvegliandosi a fine spettacolo quasi come dal canto di una bizzarra sirena, ce lo dà lei stessa, parlando proprio di Schubert.
“Quel che manca e che contemporaneamente diventa presente non è l’aura, che ogni opera d’arte possiede e che appunto la rende tale, ma il fatto che ci sia qualcosa che contemporaneamente ci viene sottratto, perché anche l’ascoltatore, mentre ascolta, viene espropriato di se stesso, per quanto sicuro di sé lui possa essere. L’ascoltatore viene per così dire risucchiato dal vuoto schubertiano, che alla fine, proprio come la musica più di nulla certa che io conosca, lo restituisce da bravo […], ma per qualche frazione di secondo, visto che il tempo, relativamente, è andato all’indietro, lo ha fatto a pezzi con questa frusta del tempo fatta di suono e si è estraniato per sempre, senza nemmeno accorgersene.” (Zu Franz Schubert [Su Franz Schubert], 1999, in Elfriede Jelinek Homepage, zur Musik).
8 Gennaio 2015

wild daheim, oil painting by Roberta Cortese to Winterreise, play by Elfriede Jelinek